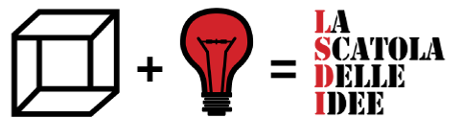Un lungo articolo, una bella intervista, due persone a confronto, questo è quello che vi proponiamo oggi.
Abbiamo trovato questa intervista significativa fatta ad Amelia Rosselli da Mariella Bettarini. Una lunga intervista e delle considerazioni su una poetessa che merita maggiore conoscienza e divulgazione, che merita il nostro amore letterario per la durezza delle sue visioni, la fatica del suo pensiero e l’umiltà della sua idea di persona letterata.
Lei era una poetessa, lei era Amelia Rosselli, che se non ci ha influenzato ci ha comunque regalato la massima “Mi fanno male i capelli” degna di tutta la sensibilità che può appartenere ad una persona e perfettamente interpretata da Monica Vitti in Deserto rosso.
http://www.youtube.com/watch?v=ZvxKiApBG_0
Ma senza voler togliere spazio ulteriore alla vostra lettura vi invitiamo ad apprezzare questo lungo articolo che ci parla di una donna che fu donna in tutta la sua sensibilità.
“La visionarietà antiermetica di Amelia Rosselli”
di Mariella Bettarini
Questa giornata di studio e di lavoro, di incontro con la voce di Amelia Rosselli è un’occasione e un evento per Firenze, una città che spesso chiama “evento” ciò che non lo è, o lo è in maniera talmente opaca e poco originale da risultare segno di vecchiezza, di stasi culturale da parte di istituzioni talora ottusamente fisse al già visto e codificato. Pur nel dolore del vuoto e dell’assenza, quest’occasione è di grande allegrezza. Amelia Rosselli è una di quelle voci che non avrebbero bisogno di nient’altro se non di conoscenza amorosa e di approfondimento; voci tanto alte e sublimi da risultare persino oscure, d’un’oscurità, però, si badi bene, tutta “antiermetica”, antiletteraria, antiaccademica, come cercherò di dire. Avrei infatti anche potuto intitolare questo intervento “La visionarietà antiletteraria di Amelia Rosselli” ma ho scelto l’aggettivo “antiermetica” perché più adatto, mio avviso, a un ambiente e a un uditorio fiorentini. Sono felice d’esser qui, d’essere arrivata a vedere questa giornata. Lo dico senza nascondere una certa soddisfazione: in qualche modo, l’incontro odierno si deve a un suggerimento, a uno “spunto” che vorrei raccontare: quando, circa un anno e mezzo fa, presentando al Circolo Rosselli un libro di Rino Capezzuoli, entrai per la prima volta in quello spazio, molto bello e molto importante di Firenze, spazio che non conoscevo, vidi sulla destra della piccola sala due grandi ritratti dei fratelli Rosselli. Mi commossi molto: le figure di Carlo e Nello Rosselli, così vive, così tragiche, mi riportarono immediamente alla mente il nome di Amelia, figura anch’essa così tragica, così importante. Con naturalezza esclamai: “Sarebbe bello che qui a Firenze, magari in questo spazio, si facesse qualcosa per Amelia Rosselli” (lei era morta purtroppo da circa un anno, allora). La città di Firenze fin lì aveva taciuto, e magari avrebbe taciuto chi sa ancora per quanto. Amelia Rosselli non credo sia ritenuta “sua” da parte dell’intellighenzia cittadina, sempre più disattenta, sfiorita. Se si escludono i cosiddetti “anni d’oro”, gli anni delle “Giubbe Rosse”, dell’ermetismo, di Montale, dei giovanissimi Luzi, Parronchi, ma soprattutto, aggiungo, gli anni di Gadda, di Palazzeschi, di Landolfi, di Piero Santi (uno scrittore vergognosamente dimenticato), Firenze è sempre stata una città avversa a scrittori e poeti di ricerca, d’avanguardia; ostile al nuovo, alla sperimentazione. Nonostante riviste come “Quartiere”, “Tèchne” e poi “Quasi”, “Salvo imprevisti”, ecc…; nonostante i poeti visivi, il “Gruppo Settanta” (e quanto fortunatamente vi si è poi mosso e vi si muove), Firenze resta una città ostile a voci “altre”, diverse; ostica ad accogliere qualunque libertà stilìstica (e dunque etica), così come a suo tempo avversa alla grandezza e novità di un poeta come Dino Campana. Una città sorda all’esigenza di allargare i propri angusti confini, le proprie provinciali idiosincrasie, i secolari steccati. Il forte, fiero cosmo polifonico della voce di Amelia Rosselli pare avvilire, umiliare l’asfittica pochezza di tanti poetini locali. Entro dunque nel tema che mi sono proposta: La visionarietà antiermetica di Amelia Rosselli. Se talora la Rosselli può avere all’apparenza qualche tono ermetico (o ermetizzante), non è assolutamente possibile sostenere, come ha fatto Giacomo Magrini nel proprio intervento, l’esistenza di un suo “debito” nei confronti della poesia di Montale. Ho letto a fondo Amelia Rosselli. Credo di aver letto tutto Montale. Leggo “da sempre” i poeti e “da poeta”, con modestia ma anche con forza, mi permetto di dire che sarebbe l’ora di smettere di valutare sempre tutto alla luce d’una obbligata, inevitabile “sudditanza” di qualcuno verso qualcun altro. La potenza della parola poetica di Amelia Rosselli è tale da non poterla certo ascrivere tra gli epigoni dell’ermetismo, un movimento poco innovatone linguisticamente, nient’affatto “profetico”, fortemente letterario. Il voler sempre e comunque trovare “padri” a certi autori (ma soprattutto autrici) è un fortissimo limite, un errore di giudizio, uno svilimento della libertà. Quando dico “libertà”, dico prima di tutto libertà da sudditanze imposte da un’idea (della) critica che obbliga a vedere in certi autori (ritenuti, dunque, in sé insufficiente, “minori”, “dipendenti da”) sempre l’ombra di qualcun altro (ritenuto indiscutibilmente “maggiore”). Amelia Rosselli è un grande poeta antiermetico, un’autrice che ha scelto una sperimentazione inesausta, del tutto originale e autonoma, frutto di un acceso e appassionato immaginario, di ampi studi letterari e musicali, di scavo psicanalitico, di razionalità coniugata a un “irrazionale” urgente e proliferante. Una donna “totale”, di grandissimo “impegno e ingegno” (non l’uno senza l’altro), fuori da qualunque torre d’avorio, rifuggente dal solipsismo di una cultura autoreferenziale. La Rosselli è stata “un apostolo” della bellezza, della libertà: libertà di parola, anzitutto, discendente da libertà di pensiero; libertà d’essere poeta con un profondo bagaglio di amori letterari, che significano aderenza e passione, non piaggeria e sottomissione a modelli prestabiliti, a canonizzate voci. In nome di questa volontà di rendere, proprio da Firenze, minima giustizia e voce a una grande voce, parlando con pudore e insieme con estrema passione di un poeta che non c’è più, ecco, in nome di tutto questo, vorrei condividere alcuni “luoghi” di lettura che mi hanno particolarmente coinvolto (ma dovrei citare all’infinito … ) partendo da quella sua particolare “oscurità” (un’oscurità “non-ermetica”, appunto), da quel suo non sapere che è una superiore forma di “sapienza” e potenza creativa:
[… ] Non so se io sì o no mi morirò di fame,
paura, gli occhi troppo aperti per miracolosamente
mangiare
[…]
lo non so se tra il sorriso della verde estate
e la tua verde differenza vi sia una differenza
io non so se io rimo per incanto o per travagliata
pena. lo non so se rimo per incanto o per ragione
e non so se tu lo sai che rimo interamente
per te […]io non
so se tu cadi o tu tremi, tu non sai se io piango
o dispero. Disperare, disperare, disperare, è
tutto un fabbricare. Tu non sai se io piango
o dispero, tu non sai se io rido o dispero.Io
non so se tra le pallide rocce il tuo sorriso.(da La libellula, 1958)
Da poeta a poeta- in linguaggio sterile, che
s’appropria della benedizione e ne fa un piccolo
gioco o gesto, rallentando nel passo sul fiume
per lasciar dire ogni onestà. Da poeta in poeta:
simili ad uccellacci, che rapiscono il vento
che li porta e contribuiscono a migliorare la
fame. Di passo in passo un futile motivo che
li rallegra, vedendosi crescere in stima, i letterati
con le camicie aperte che si abbronzano al sole
di tutte le tranquillità: un piccolo gesto sfortunato
li riconduce all’aldilà con la morte che sembra
scendere e stringerli.
Ironicamente fasulla, o v’è una verità? ch’io
possa dire anche tua?
Ma nel fiume delle possibilità sorgeva anche
un piccolo astro notturno: la mia vanità, d’esser
fra i primi gigante della passione, un Cristoemblema
delle rinunziazioni […](da Serie ospedaliera, 1963-65)
Leggiamo, dunque, leggiamo Amelia Rosselli: senza paraocchi, senza prevenzioni, senza paura. Leggiamola nella sua severità preziosa, nel suo culto per la parola cercata, adorata non come “scienza infusa”, ma come grazia e insieme “rovello”, come “sorte” ma anche come acutissima “scelta” di tutta una vita. Leggiamola, amiamola nella sua sublimità umile di fronte alla poesia: nella dedizione, nel coraggio, nel debito verso la parola e verso nessun altro se non verso i grandi, riconosciuti, taciti Maestri (che certo non possono essere coloro che impongono ed esigono ossequio). Leggiamola nel suo apparente “disordine”, nella sua “notte oscura”, nella sua voce che dice “io” visionariamente, profeticamente. Leggiamola nel miscuglio di razionalità e irrazionale, nella sua ragione musicale, nel suo ritmo come respiro; nel corpo della sua parola e nelle parole del suo corpo. Leggiamola, amiamola nell’assillo metrico, nella nera afasia, nel rischio, nel silenzio, nella scabrosità di una passione inesausta, nella ricerca immortale di “tutte le possibilità” (e “impossibilità”) della lingua. Lasciamoci travolgere da tanta forza, da tanta tragicità, grazia e bellezza. Saremo guariti da lei, dall’assoluto della Poesia. Per un’intervista inedita ad Amelia Rosselli Di Mariella Bettarini
È il 10 dicembre del lontano 1979. Siamo a Roma, Gabriella Maleti e io, per incontrare Amelia Rosselli e intervistarla per il volume Chi è il poeta? (interviste a 33 poeti), che sto curando con Silvia Batisti e che uscirà nelle Edizioni Gammalibri di Milano nel settembre 1980. Gabriella, che ho conosciuto da alcuni mesi a Milano, è con me come fotografa/poeta. Scatterà alla Rosselli decine e decine di fotografie, là, nella casa romana di via del Corallo. Nel nastro allora registrato si sente distintimante, metallico e preciso, secco e immortale, al disotto della voce inconfondibile e grave della Rosselli, il rumore dell’otturatore della macchina Contax, che scatta, scatta all’infinito. Amelia Rosselli ci riceve in semplicità nella sua ripida casa romana. Si siede al tavolo, ascolta di volta in volta le domande che le pongo (sono le medesime per tutti i poeti invitati), pacata parla, risponde. C’è un’aria intima e acuta, severità e obbedienza alla parola, intelligenza penetrante, un’umana alta esperienza. Gabriella e io ne siamo non poco toccate.
Purtroppo, poi, né intervista né fotografie saranno utilizzate, poiché la Rosselli non vorrà più comparire nel volume.
Questa che segue è dunque l’”antica” intervista rimasta inedita per circa vent’anni e riproposta oggi quasi integralmente. Dico “quasi” poiché in vari passaggi del discorso (segnalati da puntini in parentesi) la voce cupa e bellissima della Rosselli risulta pressoché inudibile, tanto i toni sono bassi. Stefano Giovannuzzi ne ha fatto una trascrizione accuratissima e il più possibile fedele; trascrizione che con emozione e gioia proponiamo al lettore.
giugno 1999
INTERVISTA AD AMELIA ROSSELLI
Mariella Bettatini: Siamo a colloquio con Amelia Rosselli, alla quale stiamo ponendo alcune domande per il libro che uscirà a Milano con la Gammalibri. La prima domanda è questa: a circa quindici anni dall’uscita del Mestiere di poeta di Ferdinando Camon e ormai abissalmente lontani da quegli anni Sessanta che cosa resta, se resta qualcosa, del mestiere di poeta? E che significa oggi, alle soglie degli anni Ottanta, essere poeti in Italia? È possibile essere poeti in una società antiletteraria come la nostra?
Amelia Rosselli: I miei discorsi sarebbero sempre un po’ particolari, perché, piuttosto che generalizzare sul tema, cosa significa essere poeti nella civiltà di oggi, mi riesce più facile parlare di incidenti specifici. Veramente non ho mai saputo perché sono stata scrittrice negli anni ’54, ’55, ’60 e ’70. Oggi so perché non lo sono, ma dare le spiegazioni è un po’ seccante qualche volta.
Direi che son diventata scrittrice senza deciderlo; avevo fatto studi di musicologia, di composizione e musicologia; ero molto legata alla musica. Forse sono stata influenzata dall’ambiente romano, ho frequentato molti scrittori, pittori, senza prendere una netta decisione riguardo al professionalismo nello scrivere, fino a ventinove anni e questo per ragioni di necessità, perché mi accorgevo che gli studi molto specializzati di musicologia non mi avrebbero mai permesso di trovare lavoro, anzi spendevo piuttosto che guadagnare. E allora notando che avevo molti manoscritti, istintivamente, spontaneamente ammucchiati, ho fatto un piccolo calcolo di tutti i giorni, cioè pubblicare e poi eventualmente trovare lavoro.
Avevo un grande amico in quell’epoca, ed era negli anni Cinquanta, era Roberto Bazlen, chiamato Bobi, in realtà era un consulente prima di Einaudi e poi Adelphi ed è quello che ha portato in Italia molta della letteratura spagnola [… ]. Lui predicava piuttosto il non pubblicare: per me prendere una decisione di pubblicare fu quasi blaspheme, blasfemo si dice, scusa. Non era la mia intenzione far parte di un ceto intellettuale, anche perché non mi consideravo strettamente intellettuale, evitavo un po’ l’esserlo e un pochino ero in continua corsa contro il tempo, contro la società stessa, avendo avuto una formazione anglo-americana e francese, con culture diverse, spesso a livello più basso e avendo fatto solo il liceo, a parte gli studi specializzati. Non mi sentivo all’altezza di un ambiente letterario quale io avevo conosciuto a Roma e non solo all’altezza: non mi piaceva l’ambiente letterario in quanto borghese, per quel poco che l’avevo conosciuto tramite Levi e Rocco Scotellaro, avevo conosciuto i salotti e non solo non capivo molto di quel che dicevano, essendo d’altro ambiente, ma provavo angoscia e sensazione di rifiuto nei confronti della borghesia, così netto, da non pensare me stessa in quell’ambiente. Dunque, devo dire che, se ho pubblicato, malgré moi, ho pubblicato per ragioni di opportunità e il più tardi possibile. Ho cominciato a pubblicare a trentatré anni, mandando il manoscritto a Vittorini, anche ad altri editori che non risposero, il primo manoscritto, che era Variazioni belliche: fu il primo libro compiuto in italiano. E, strano a dirsi, Vittorini mi rispose e mi chiese ventisei poesie per il “Menabò”.
Poi per caso ho incontrato Pasolini da Moravia e, sudando freddo, gli ho chiesto se mi aiutava a pubblicare l’intero libro. A lui piacque, inaspettatamente: io ero entusiasta del suo lavoro, perché avevo visto Accattone. Non avevo in realtà molto seguito i letterati della mia generazione, a parte un ristretto gruppo di amici. Studiavo continuamente gli inglesi, gli americani, i francesi, le traduzioni, anche l’italiano classico, ma non l’italiano moderno; non mi sentivo vicina alla poesia di Pasolini in quell’epoca. La lessi dopo. Se non ci fosse stato Pasolini, non ci sarebbe stata pubblicazione, questo è sicuro, perché gli altri tre o quattro editori non risposero. E se non ci fosse stato Vittorini, non ci sarebbe stato Pasolini, perché Vittorini appoggiava sul “Menabò”, si interessava al libro, che per qualche ragione lo toccò.
Se mi chiedi qual è la funzione dello scrittore oggi, in questa società, la sento ancora meno e la vivo artificialmente, la vivo non per scelta; per scelta di vocazione sì, nel senso che è stato istintivo […], ho scritto addirittura cinque o sei libri, però ne ho pubblicati tre, ne esce un quarto con Guanda, forse. Ma da giovane non mi sarei mai sognata scrittrice, anche perché non lo considero un mestiere. Sono stata educata al guadagno, cioè al doversi mantenere, da una madre abbastanza severa, inglese, e mi sarei vergognata di chiamarmi scrittrice in quell’epoca e tuttora me ne vergogno. Non amo la distinzione tra intellettuale e non intellettuale, mi fa arrossire, sto ancora […] corsa dietro una sufficiente cultura, una cultura completa, in modo da guadagnare in termini … E, quanto alla funzione dello scrittore oggi in questa società, anzi è calato il significato. Forse è un bene. Il significato di guida dell’intellettuale, che riesce molto meno ad influenzare quella che ora sappiamo essere una massa e non una borghesia, e non si illude di influenzare la massa, perché è interessante piuttosto che la massa si avvicini allo scrittore, non lo scrittore alla massa.
Ho molti amici di origine o piccolo-borghese o figli di impiegati o operai delle periferie, che ho conosciuti circa, quasi otto anni fa. Ho visto le loro case, ho visto che non hanno più di quaranta libri in camera e vedo che scrivono, e vedo che hanno passione per la poesia, il che mi ha lasciato sempre molto sorpresa. Anche con un bagaglio culturale ridotto sembrano avere un autentico amore per la letteratura. Quello che spaventa è che hanno anche l’amore per la fama letteraria e mi chiedo se non è una forma di imborghesimento proletario questa, cioè la mimica della borghesia. Sembra essere, perché lo vedo succedere non in un gruppo o in un genere e nemmeno in una classe e non solo nella piccola borghesia, ma tra gli altri, tra operai, gente che fa l’operaio per la SIP e scrive versi. Solo quello che noto è […] di lettore studiando sempre meno e scrivono sempre meno col tempo, si sposano, fanno un figlio e non hanno più tempo per nulla e il passaggio al professionalismo, anche se la parola è laida, non lo scrivere: non so se avverrà mai in un certo luogo di lavoro è obbligatorio e la famiglia una necessità per sopravvivere. Oppure loro stessi mancano del nostro spirito cosiddetto eroico: non ci sposavamo, non facevamo figli, pur di seguire questa istintiva vocazione. Almeno questo fu nel mio caso. In loro non c’è questo eroismo e nella massa di oggi che si interessa all’arte non c’è questo eroismo e, se ci sono casi singoli, sono casi rari, come lo sono sempre stati.
M.B.: La seconda domanda si riallaccia alla prima e direi che in parte forse la risposta è già qui: Il rapporto fra scrittura e biografia, fra versi e vita, una “vita in versi”, tra uomo, donna e poesia, tra letteratura e storia di sé, tra individuo e poeta. Vorremmo che ci parlassi di questo. In che modo interagiscono, a tuo parere, questi due elementi, questi due inevitabili ed indissolubili poli, all’interno di una dinamica quotidiana, personale, familiare, storica, anche in relazione ai problemi economici, pratici, del lavoro quotidiano, quello che, per intenderci, dat panem?
A.R.: Il grosso difetto della letteratura femminile o un pochino femminista oggi è quello di essere orgogliosa. È la pecca numero uno del femminismo letterario. lo ho letto insieme a delle femministe dei libri [… ] e mi è dispiaciuto vedere questo tema di fondo. […]. Non sanno uscire dalla loro vita privata. La denuncia è sempre, se non dell’uomo, dell’infelicità della vita […] e la poesia è anche [… ]. Se non sublimano, non esiste. Per me tanto vale che venga a raccontarmi i suoi fatti privati, anzi forse mi son più utili, lei è più utile a me allora a quattr’occhi che non pubblicandomi versi che […] sulla sua vita privata. Anzi, è il più grosso problema, perché, vedi, è l’uscita dall’io, e perfino è l’uscita dal rapporto col pubblico italiano, come uscirne e come raggiungere almeno un’obbiettivazione, una sopraelevazione, come uscire da se stessi. Nessuno ha voglia di scrivere di sé, salvo che trasfigurando l’esperienza e nascondendosi quanto più possibile dietro le scene evitando addirittura la parola l’io”. E spesso io ho avuto il problema di evitare la parola “tu”.
Se tu parli a un “tu” in una poesia, tu parli se non a un tuo amore, certo a un tuo compagno o una tua compagna e il rapporto è a due, dunque non necessariamente da pubblicarsi, anzi, da non pubblicarsi. Se il rapporto diventa plurale, si può parlare di un discorso ad un pubblico; se non è al plurale, tanto vale non farlo.
M. B.: Dunque, l’ultima domanda, la più lunga ed è questa: a tuo giudizio, il testo basta a se stesso oppure no? Il lettore ha o non ha diritto a conoscere l’uomo, la donna-poeta, la sua realtà pretestuale ed extratestuale? Quale rapporto indica in definitiva fra la carta, quella stampata, i libri, la faccia esterna, pubblica, nota, e la carne, la persona, la faccia interna, privata, ignota? Per superare il mito del poeta e l’eventuale automitizzazione non ritieni che sia importante che chi legge versi conosca anche l’uomo, la donna, l’individuo e non soltanto il testo? Sappia il corpo e le sue manie, smanie, acciacchi, dolori, persecuzioni, vite e morti, non soltanto l’olimpica testa, produttrice somma di testi? È una domanda polemica.
A.R.: No, se l’avessi fatta a Pasolini questa domanda, ti avrebbe risposto come ha risposto sempre, sia tramite i versi e sia tramite la sua vita, però parlando di sé, ma così universalmente da riuscire a toccare proprio … Purtroppo era anche un suo lato debole, perché parte della sua ultima poesia, secondo me tecnicamente inidonea, proprio perché c’è questo rotolarsi nel proprio fango, ma fango in senso morale. Solo perché è morto quegli ultimi libri si svegliano, danno qualcosa, ma è una ben patetica luce. Non si può confrontare il film Accattone o Le ceneri di Granuci con nessuno degli ultimi libri, che non mi entusiasmavano proprio per quel lato confessionale. E adesso in America c’è addirittura una scuola poetica chiamata “confessionale” e non so perché la trovino tantoo originale, perché … è una scuola che non solo c’è stata sempre, è una scuola che fa paura ai dilettanti. Figurati a chi si è posto il problema da quando ha cominciato a scrivere, se confessare la vita privata o no. Io no, non sono per niente di quel parere; mi pare anzi che le piccole note biografiche che gli editori ci chiedono per i libri sono prodotti che servono al pubblico, oppure le interviste, pian pianino … Se vogliono saperne di più, l’autore è a disposizione del pubblico, ma non è detto che debba esserlo la sua poesia, non è schiavo del pubblico e non è detto che il pubblico voglia la sua vita privata. Non sappiamo nemmeno questo. Abbiamo veramente sondato il pubblico, quale pubblico, quale tipo di gruppo, e l’abbiamo sondato? Abbiamo mai chiesto al pubblico se voleva anche fatti intimi o risposte universali? Cosa che importa attenzione e sul chiedere, oltre che dare, ma […] intimi. Ho notato, per esempio, quando abbiamo fatto le letture la prima volta per un grosso pubblico, quest’estate al mare, Roma, a Castelporziano, che il pubblico si impazientiva con qualsiasi atteggiamento privatistico o esibizionistico, commercialistico: perfino fischiavano e sbattevano fuori i troppi fotografi, la televisione, il poeta che faceva il dialoghino col pubblico, per poi chiamarlo fascista perché li fischiava. Io ho sentito da parte del pubblico, che non era un pubblico terribilmente interessante, perché era per metà borghese, essendo tutta gente che poteva andarci in macchina, per un terzo gente che era già al mare e per pigrizia è rimasta là, e ci sarà stato un ottavo del pubblico popolano e questionante, che chiedeva una sostanza al teatro in tutte le sue creature. Ma l’ambiente […] e violentemente fischiavano qualsiasi cosa non fosse dono di contenuto, dono di ricerca e risposta. Era un pubblico, direi grosso modo un pubblico piccolo-borghese, tirando una media. La mia netta sensazione è stata questa. Ho letto per ultima, o verso la fine della prima sera e sono riuscita a seguire, a sentire il pubblico […], so soprattutto e nettamente questo: che volevano qualcosa di serio, un po’ di cibo spirituale; gli si dava spettacoletti o insulti o scherzi, con ragazze drogate o ballerine; si è molto irritato ed ha sbattuto molte sedie. E appena gli davi qualcosa di serio, erano zitti ed ascoltavano con attenzione. Io non sottovaluto il pubblico, anzi mi ha divertito un pubblico così, mi è piaciuto il suo non volere l’eccesso di pubblicità che c’è stato.
Comunicazione presentata, insieme all’intervista inedita, al Convegno di Studi Un’apolide alla ricerca del linguaggio universale (a cura di Stefano Giovannuzzi), organizzato a Firenze presso il Gabinetto Viesseux il 29 maggio 1998, i cui atti sono raccolti nel n. 17 (1999) dei Quaderni del Circolo Rosselli.