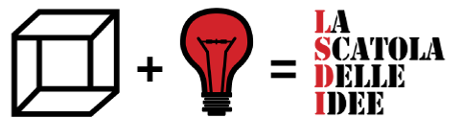Intorno al film
Il cinema di denuncia italiano, colonna portante negli anni d’oro fra i Sessanta e i Settanta, continua a fare scuola non solo come arte cinematografica ma anche come veicolo di impegno civile e insegnamento. Accanto ai vari maestri Damiani, Rosi, Petri e via dicendo, si scopre anche un film come Corruzione al Palazzo di Giustizia (1974) di Marcello Aliprandi, un’opera magari non perfetta come altre ma talmente appassionante, caustica e di continua attualità che ci si stupisce di come spesso rimanga sotto silenzio.
Oggi i film davvero notevoli in tal senso sono abbastanza rari – a marzo è uscito nelle sale La macchinazione di David Grieco, in precedenza ricordiamo le ricostruzioni storiche come Il divo, Diaz e Romanzo di una strage, oppure i connubi con il genere noir/poliziesco quali ACAB, Suburra, Gomorra e Arrivederci amore, ciao.
Facendo un tuffo nel passato, in quei gloriosi anni Settanta che hanno partorito i capolavori del genere (e non solo), capita con piacere di imbattersi in pellicole che non hanno la stessa nomea di altre ma sono ugualmente valide e meritorie di essere riscoperte. La stessa sorte toccata al suo valido regista, quell’Aliprandi che ci ha consegnato un pugno di pellicole di spessore e che meriterebbe più attenzione critica: dallo sci-fi satirico La ragazza di latta al nostro film, dal thriller parapsicologico Un sussurro nel buio al fantapolitico Morte in Vaticano, passando per l’horror televisivo La mano indemoniata e altri film-tv.
La vicenda
In un’imprecisata città italiana, i giudici del tribunale cercano da tempo di incastrare il potente industriale Carlo Goja (Martin Balsam), responsabile di corruzione e reati vari ma al di sopra di ogni sospetto, tanto più adesso che si è anche candidato in politica. Le indagini sembrano giungere finalmente a una svolta quando viene scoperto il suo archivio segreto, custodito nei sotterranei di un ospizio, che consentirebbe di fornire le prove dei misfatti. Mentre il giudice Dani (Franco Nero) si sta recando sul luogo, una telefonata anonima avverte Goja di quanto sta per accadere, e alcuni sicari provvedono a incendiare l’archivio provocando anche la morte di un’anziana signora. È chiaro che la soffiata proviene direttamente dagli uffici del Palazzo di Giustizia, e che quindi qualcuno tra i funzionari è corrotto dall’industriale: per ordine del Ministro degli Interni, arriva per le indagini l’ispettore Erzi (Umberto Orsini), mentre il sospetto serpeggia e i giudici si accusano l’un l’altro. Fra i maggiori sospettati c’è addirittura Vanini (Fernando Rey), il Presidente del tribunale, ma Dani – che collabora con l’ispettore – indirizza le sue attenzioni anche sull’ambiguo giudice Prandò (Gabriele Ferzetti), futuro candidato alla presidenza e che avrebbe quindi validi motivi per screditarne la figura.
Narrazione e stile
Il cinema italiano cosiddetto “di denuncia”, volto cioè a indagare le magagne del sistema politico, economico e giudiziario del Belpaese con una forte componente di impegno civile e intellettuale, non è in realtà un filone unico, visto che si trovano al suo interno le narrazioni e gli stili più differenti fra loro: ci sono i polizieschi di Damiani e Squitieri, abili come pochi altri a coniugare impegno e spettacolo; l’astrattismo metafisico di Petri, in cui la realtà è filtrata da uno sguardo surreale; i drammi grottesco-satirici di Risi, Monicelli e Zampa; lo sguardo di Rosi, Ferrara e Lizzani, che coniugano il noir con uno stile semi-documentaristico; c’è Fernando Di Leo, che con le sue analisi della malavita, della mafia e delle connivenze col potere politico si è beccato più di una denuncia per le scomode verità messe in scena; e poi ci sono i vari Pasolini, Bellocchio, Montaldo, Pontecorvo, Bertolucci, Vancini. Insomma, un numero immenso di registi e relativi film. Poi, rovistando fra questi grandi film, si trovano delle “schegge impazzite”, opere realizzate da registi meno conosciuti ma di innegabile valore, magari autori di pochi film l’uno diverso dall’altro ma che hanno sempre saputo cogliere nel segno: è il caso di Massimo Pirri con il fanta-politico Italia: ultimo atto?, o appunto del nostro Marcello Aliprandi con l’ottimo j’accuse Corruzione al Palazzo di Giustizia.
Il film in oggetto è tratto dall’omonimo testo teatrale del drammaturgo Ugo Betti: un dramma in prosa in tre atti composto nel 1944, un atto d’accusa ambientato originariamente in epoca fascista ma che gli sceneggiatori del film (Aliprandi, Clerici, Imbert) traspongono in età contemporanea: in realtà, l’anno e il luogo non vengono volutamente precisati e il film ne guadagna un’aurea quasi metafisica che lo accosta parzialmente alla filmografia di Elio Petri, pur non raggiungendone le vette di perfezione. Significativo è l’apporto in fase di sceneggiatura di Gianfranco Clerici, uno fra i più attivi e poliedrici nel cinema italiano dagli anni Sessanta a fine anni Ottanta, che ha scritto con eguale dimestichezza film polizieschi e gialli, horror e commedie, erotici e di guerra, e che adatta magnificamente un’opera teatrale in uno script cinematografico – impresa tutt’altro che semplice. Il fatto che la storia sia ambientata negli anni Settanta lo deduciamo da location, scenografie, vestiti e automobili, perché non c’è nessuna indicazione cronologica né tantomeno geografica: potrebbe essere Roma, ma anche qualsiasi altra città. E tutto ciò è un valore aggiunto: perché Corruzione al Palazzo di Giustizia vuole rappresentare le storture politico/giudiziarie che affliggono un intero Paese, non un luogo particolare, e probabilmente la “città” immaginata da Aliprandi è un macrocosmo che simboleggia tutta l’Italia; e, come testimonia lo slittamento cronologico dal testo teatrale al film, mette in scena una storia veritiera tanto in epoca fascista quanto nei seventies, ma anche negli anni a venire. Scrutando nella trama e nei dialoghi, numerosi sono i tasti dolenti che vengono toccati: corruzione di politici e magistrati, industriali spregiudicati che scendono in politica, inquinamento ambientale, prove fatte sparire, la necessità di ridare fiducia ai cittadini nella giustizia e di riformare la medesima, l’impiego più o meno legittimo delle intercettazioni, le lotte intestine fra i giudici del tribunale; è difficile guardare il nostro film senza pensare a tutto quanto accade oggi, tra scandali, episodi di corruzione, collusioni occulte, indagini, verità messe a tacere. Un film dunque profetico, come tante pellicole di impegno civile realizzate in quegli anni, a testimonianza di come i registi abbiano saputo – più o meno volontariamente – vedere al di là dei loro tempi realizzando opere che rimangono di scottante attualità.
In un film di impostazione abbastanza teatrale, come è logico che sia trattandosi di una riduzione da uno spettacolo di prosa, è naturale che l’ambientazione sia costituita quasi interamente da interni, che la recitazione sia molto carica e pronunciata come sul palcoscenico, e che i dialoghi abbiano un ruolo fondamentale nella vicenda: questi sono i punti cardine della natura dell’opera.
Corruzione al Palazzo di Giustizia è lontano da ogni enfasi spettacolare, nonostante sia ritmato e orchestrato come un giallo giudiziario, e si discosta pure dalla satira o dallo stile documentaristico: come si accennava, il riferimento più vicino – lo stile narrativo a cui più assomiglia – è il cinema di denuncia di Elio Petri. Dal capolavoro indiscusso Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto allo sci-fi grottesco La decima vittima, dal giallo di ambientazione mafiosa A ciascuno il suo all’apologo La classe operaia va in paradiso, fino a Todo modo, il maestro Petri ha sempre affrontato la denuncia della realtà (polizia, mafia, Potere, classe operaia, classe politica) filtrandola attraverso uno sguardo astratto, surreale, anche metafisico in certi momenti (raggiungendo lo zenit con Todo modo), eppure al contempo in modo incredibilmente concreto e aderente alla realtà. Persino Indagine, il suo film più concreto e “poliziesco” (è stato definito quasi “all’americana”), è impregnato di questo spirito rarefatto che rende inconfondibile il suo stile e il suo modo di raccontare. In Corruzione al Palazzo di Giustizia siamo un po’ da queste parti, a cominciare dalle ambientazioni claustrofobiche e geometriche, con inquadrature ossessive e la fotografia (Gastone Di Giovanni) che predilige i toni grigi: la maggior parte della storia è ambientata proprio all’interno del Palazzo del titolo, fra i suoi saloni e ambulacri, corridoi, scale, archivi polverosi, uffici in cui ciascuno sembra continuamente spiare gli altri, un ristorante interno al tribunale dove bizzarri personaggi si scambiano notizie e pettegolezzi, oltre alla lussuosa abitazione del Presidente Vanini; anche molti esterni sono di stampo petriano, in particolare la lunga scalinata che conduce al tribunale e le maestose colonne poste all’ingresso che danno un senso di inquietante vertigine. Corruzione al Palazzo di Giustizia alterna continuamente, e in modo riuscito, questo stile in parte grottesco e surreale (per tutto quanto si è detto) con una struttura da noir giudiziario fortemente realistico e concreto, un po’ alla Damiani (Perché si uccide un magistrato) e persino vagamente “all’americana” (Tutti gli uomini del Presidente, E giustizia per tutti). L’inizio tesissimo con la musica ritmata di Pino Donaggio che accompagna l’auto del Ministro scortata da due moto della polizia stradale, l’incidente provocato per ritardare l’arrivo dei giudici all’archivio, il sequestro di una testimone, la breve lotta per impadronirsi della valigetta col dossier incrementano il ritmo della vicenda, ma non siamo in un film poliziesco, per cui non c’è azione e tutto è affidato ai dialoghi e a una sceneggiatura complessa (anche troppo in certi momenti) dove agiscono i numerosi personaggi, tra colpi di scena e sviluppi imprevedibili in una trama dal ritmo serrato.
Aliprandi non ha la mano e l’esperienza dei maestri citati, ma il film funziona a meraviglia grazie alla sceneggiatura rigorosa, ai dialoghi pregnanti (in particolare sui concetti di giustizia e dintorni) e a un cast superbo: la produzione è evidentemente abbastanza grossa, potendosi permettere non solo un protagonista come Franco Nero (in quegli anni al vertice della carriera), ma anche co-protagonisti di altrettanto spessore e con nomi internazionali. Tutti danno vita a personaggi robusti e ben caratterizzati, coi volti giusti nei ruoli giusti: dall’integerrimo (almeno in apparenza) giudice Dani di Franco Nero all’austero Presidente a cui dà il volto il buñueliano Fernando Rey, dall’ispettore che pare un burocrate fascista (Umberto Orsini, che ricordiamo ne La caduta degli dei di Luchino Visconti) al malfattore Goja (Martin Balsam, presenza ricorrente nel cinema italiano del periodo spesso in ruoli di boss mafioso), fino all’ambiguo giudice Prandò (Gabriele Ferzetti), claudicante e malandato ma che scopriremo avere al suo arco più frecce del previsto; se le figure femminili sono un po’ stereotipate, spicca invece il misterioso politico noto come Eccellenza, viscido e untuoso anche fisicamente, grasso e coi capelli lucidi, interpretato dall’ottimo caratterista Umberto D’Orsi. Particolarità del film è che, in fondo, tutti risultano essere protagonisti fondamentali per questo complesso e amaro puzzle che diventa man mano intricato come un giallo senza però mai perdere di vista i punti focali: la denuncia della corruzione e la rappresentazioni di questi personaggi sospesi tra un crudo realismo e un certo gusto per l’esagerazione grottesca, una spietata analisi che accompagna i protagonisti nei pericolosi gangli del Potere, una discesa “agli inferi” non solo metaforica ma anche fisica (dagli uffici all’immenso archivio sotterraneo, custode di chissà quali segreti).
Ci sono alcune sequenze particolarmente riuscite e che rendono Corruzione al Palazzo di Giustizia un film memorabile. La scena dove alcuni cabarettisti all’interno di un locale si esibiscono in uno spettacolo di satira contro Goja in presenza del medesimo, con la moglie che grida allo scandalo e l’uomo che la tranquillizza dicendo che è “tutta pubblicità” per lui (un momento profetico di tante situazioni odierne). La sequenza in chiesa dal sapore quasi “padrinesco” in cui Eccellenza si accorda in segreto col Ministro per destituire il Presidente Vanini, sullo sfondo della Messa in celebrazione di un matrimonio. Il confronto tra Nero e Ferzetti nel polveroso archivio: una tesissima guerra di nervi fra l’anziano giudice che ha scoperto la colpevolezza dell’insospettabile magistrato e il medesimo che cerca disperatamente il fascicolo incriminato, un duetto claustrofobico fra due bravissimi attori con Nero che sembra impazzire di fronte all’avversario. Infine, il momento pre-conclusivo in cui Nero cerca di ammettere la sua colpevolezza di fronte al Ministro e ai funzionari rimanendo però inascoltato e ottenendo la carica di Presidente: quel Potere a cui anelava al punto di tradire la giustizia, è finalmente nelle sue mani, ora ne è persino spaventato ma non può più tirarsi indietro; un passaggio davvero significativo, paragonabile per certi versi alla conclusione di Indagine di Petri: l’uomo di Potere rimane al di sopra di ogni sospetto. Non mancano, in opposizione, alcune scene meno riuscite che non inficiano però il risultato complessivo: i confronti pseudo-amorosi tra Franco Nero e Giovanna Benedetto nel ruolo di Elena, figlia tormentata di Vanini, che risultano un po’ finte e stereotipate; il sequestro di Flavia (Mara Danaud), amante di Goja e Vanini, per mano di due sicari mandati dall’industriale per convincerla a tacere. Tale sequenza, che poteva essere dura come in un vero noir se fosse stata diretta in altro modo, risulta invece una specie di farsa che stona inspiegabilmente con l’atmosfera generale: i due malfattori (burloni e poco credibili) imprigionano la donna in un campo dove la minacciano e sparano a un muro; la violenza vera e propria non viene mostrata – sapremo che è stata violentata solo tramite il dialogo successivo fra la Danaud e Fernando Rey – e la sequenza risulta così abbastanza sterile. Aliprandi centra invece il bersaglio praticamente sempre nel resto dell’opera, quando si tratta di analizzare la psicologia dei personaggi e le spirali del Potere.
La colonna sonora
La colonna sonora è affidata a Pino Donaggio, celebre sia come compositore di musiche per film sia come cantautore. Il musicista è una garanzia, non delude praticamente mai quando è chiamato all’opera, ed egregio è anche il lavoro che svolge per Corruzione al Palazzo di Giustizia. Le sue note svettano fin dall’incipit, quando l’orchestra suona in modo ritmato e stridente creando un’atmosfera di tensione che accompagna l’arrivo del Ministro al tribunale (uno stile po’ alla Riz Ortolani), intervallando le immagini coi titoli di testa. I brani sincopati come questo accompagnano sono abbastanza ricorrenti nel film, contribuendo ad aumentare il clima di suspense e sospetto generale, mentre nei momenti di calma (per esempio gli incontri fra Nero e la Benedetto) Donaggio crea sonorità più romantiche e malinconiche.