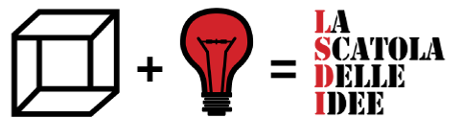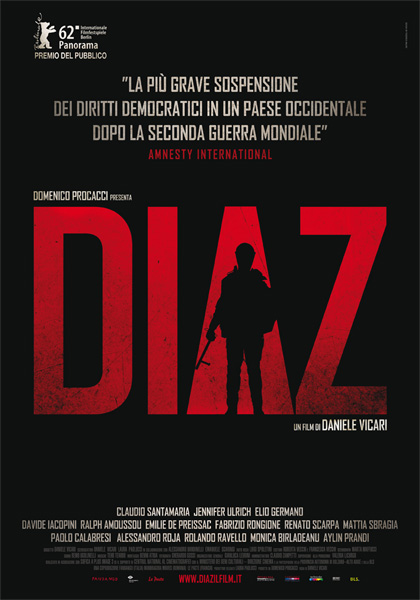Intorno al film
Quella che Amnesty International ha definito “La più grave sospensione dei diritti democratici in un Paese occidentale dopo la Seconda Guerra Mondiale” – cioè i fatti di sangue della Diaz e Bolzaneto durante il G8 di Genova nel 2001 – sono stati trasposti sul grande schermo per mano di Daniele Vicari nel film Diaz (2012). Un’opera di terribile impatto emotivo, un racconto cinematografico in cui personaggi immaginari (ma riconducibili alla realtà) si mescolano alla fedele rappresentazione dei fatti storici: i brutali pestaggi messi in atto dal reparto celere sugli inermi cittadini, le torture fisiche e psicologiche, il preciso disegno repressivo della Questura. Vincitore di vari David di Donatello e Nastri d’Argento, racconta in modo tremendamente lucido e realistico una ferita sempre aperta nella recente democrazia italiana, tanto da risultare uno fra i più potenti film di denuncia italiani di sempre. Don’t clean this blood, recita il sottotitolo: “Non lavate questo sangue”, cioè non dimentichiamo, teniamo viva la memoria: e l’opera di Vicari in tal senso è più che mai necessaria, oltre che di alto valore cinematografico.
La vicenda
I fatti storici sono noti: nella notte del 21 luglio 2001, verso la fine del G8, 93 persone di età e nazionalità differente si trovarono a pernottare nella scuola Diaz, sede del Genoa Social Forum. Nonostante l’assenza dei black bloc – gli anarchici più violenti ed estremisti – poco prima della mezzanotte centinaia di poliziotti divisi in battaglioni irruppero nella scuola, iniziando uno spietato pestaggio a colpi di manganelli, senza che nessuno opponesse resistenza: un massacro di inaudita violenza che causò numerosi feriti gravi. Successivamente, molti dei presenti furono arrestati e portati nella caserma di Bolzaneto, dove proseguirono le violenze. Nel film, seguiamo questa triste vicenda attraverso vari punti di vista. Max Flamini (Claudio Santamaria), comandante del VII nucleo della celere, l’unico che cerca di mantenere una certa lucidità e limitare i danni; Alma Koch (Jennifer Ulrich), un’anarchica tedesca che si occupa di cercare i dispersi insieme agli amici Marco e Franci del Genoa Social Forum; Luca Gualtieri (Elio Germano), giornalista della Gazzetta di Bologna che decide di recarsi a Genova per vedere di persona quanto sta succedendo. Accanto a loro giornalisti, un pensionato della CGIL, alcuni black bloc francesi, e i funzionari di polizia che hanno organizzato l’irruzione.
Narrazione e stile
Daniele Vicari nasce come documentarista, ed esordisce nel lungometraggio a soggetto nel 2002 con il noir Velocità massima, genere che riprende in seguito con Il passato è una terra straniera: documentario e cinema “in nero” sono due fra le cifre caratteristiche del cinema di Vicari, che confluiscono in Diaz. Quella di Vicari, regista non alle prime armi ma neppure navigato, è un’impresa durissima: non solo per la logistica (produzione complessa e ricostruzioni varie), ma anche e soprattutto perché trattare un pezzo di Storia italiana così delicato e relativamente recente è quanto di più complesso si possa immaginare. Eppure Vicari riesce a realizzare nel migliore dei modi uno tra i film italiani più riusciti e coraggiosi degli ultimi anni, che riprende la tradizione del cinema di denuncia più scomodo, riuscendo a trovare quell’equilibrio necessario fra cronaca, denuncia e racconto cinematografico di ampio respiro, serrato e spettacolare (per quanto si possa parlare di spettacolo in una storia così drammatica). Il tutto avvolto in un’atmosfera opprimente e cupa, nelle lunghe sequenze notturne ma anche nelle scene diurne, sia negli esterni sia negli interni, grazie alle scenografie minuziosamente ricostruite e all’ottima fotografia di Gherardo Gossi.
Notevoli non solo le imponenti ricostruzioni e il crudo realismo delle scene di violenza, ma anche le scelte narrative: mescola la Storia con le storie di personaggi fittizi (ma fino a un certo punto); evita il rischio di trasformare il cinema in pura cronaca documentaristica (come accade in pellicole pure notevoli come Il caso Mattei di Francesco Rosi e Il caso Moro di Giuseppe Ferrara) e riesce a realizzare “Un’opera la cui tenuta emotiva e spettacolare è davvero encomiabile”, come scrive Giona A. Nazzaro su FilmTV; mostra i fatti da differenti punti di vista e li filtra con gli occhi di vari personaggi – ogni prospettiva è introdotta dal lancio di una bottiglia di vetro che si infrange per terra; apre lo sguardo su vari fronti, tra fatti di cronaca e risultati delle indagini, in modo che lo spettatore sia messo di fronte alla realtà nuda e cruda e possa riflettere su tutto quanto accaduto in quei tragici giorni.
Diaz inizia con la singolare immagine del rewind di una bottiglia rotta – il leit-motiv di cui si parlava prima – che si ricompone fino a tornare nella mano che l’ha scagliata, per poi dare spazio a scene di guerriglia urbana: black bloc che devastano vetrate e auto, bombe molotov, lancio di sassi, cariche della polizia, lacrimogeni, strade spoglie e desolate. Sequenze dal sapore quasi apocalittico, a dimostrazione di come Vicari voglia mostrare una violenza a 360 gradi che non risparmia nessuno, per poi concentrarsi sugli abusi di potere. Parallelamente, entrano in scena man mano i vari personaggi: Elio Germano, sconvolto dall’omicidio di Carlo Giuliani e desideroso di conoscere dal vivo la realtà, Claudio Santamaria, che rifiuta di caricare gli antagonisti per evitare una carneficina, l’attrice tedesca Jennifer Urlich e i suoi amici del Genoa Social Forum, un gruppo di black bloc capeggiati dal nero Etienne (Ralph Amoussou), il pensionato (Renato Scarpa, vecchio caratterista del cinema italiano), gli alti funzionari di polizia interpretati magnificamente dal tetro Mattia Sbragia e da Antonio Gerardi (celebre nel ruolo di Antonio Di Pietro nell’ottima serie-tv 1992 su Tangentopoli e dintorni), l’economista Nick Janssen (Fabrizio Rongione) e tanti altri. Diaz è un film profondamente corale, in cui è difficile trovare un vero e proprio attore protagonista, perché tutti i personaggi sono una componente importante di questo ritratto storico-sociale a tinte nerissime. La vocazione originaria di Vicari per il documentario si vede nel periodico inserimento di filmati reali in mezzo alle ricostruzioni degli scontri, il che fa da trait-d-union con la realtà e favorisce una ricostruzione fedele degli incidenti. Tutti i protagonisti dialogano e si alternano in modo frenetico, costringendo volutamente lo spettatore a uno sguardo ampio ed elastico su quanto accade: la tenuta emotiva è veramente alta, e anche quando non accade nulla c’è la percezione – nelle parole dei presenti e in alcuni indizi come il minaccioso arrivo di Sbragia – che qualcosa di grosso stia per accadere; e a questo contribuisce in modo determinante l’eccellente e frenetico montaggio di Benni Atria, abile nell’alternare e incrociare le varie sequenze e i rapporti spazio-temporali, convogliando in un ritmo sempre più sincopato che sfocia in quello che è il nucleo del film, cioè il massacro del titolo.
Tutti i personaggi hanno nomi fittizi per ovvi motivi, ma sono riconducibili alla realtà, in particolare gli agenti e i funzionari di polizia responsabili dell’accaduto: Vicari, che scrive il soggetto ed è anche co-autore della sceneggiatura, si è documentato rigorosamente attraverso le testimonianze e gli atti del lungo processo. Da un lato la regia esplora i meccanismi interni al Genoa Social Forum (vedasi la scena della riunione) e i rapporti fra i vari protagonisti (oltre ad alcuni cenni sulle frange più estremiste), dall’altro dedica ampi momenti al retroscena che ha preceduto i fatti di sangue: sono mostrati chiaramente, e coraggiosamente, gli alti funzionari della Questura che pianificano l’irruzione solo per dare una prova di forza, costruendo prove ad hoc contro i presenti (le due bottiglie molotov portate dentro la scuola) e fornendo una provocazione come pretesto (l’auto della polizia che passa davanti all’edificio e viene aggredita). Insieme alle lunghe sequenze nella Diaz e a Bolzaneto, i dialoghi negli uffici della Questura puzzano di regime autoritario e di sospensione della democrazia, con i lati più oscuri dello Stato, della Polizia e del Potere che vogliono affermare la loro forza passando sul sangue di inermi cittadini (“Mai uno schiaffo così preciso al potere”, scrive Malcom Pagani sul Fatto Quotidiano).
L’irruzione nella scuola Diaz ha un impatto emotivo tremendo, tanto più sapendo che ogni scena che vediamo riproduce qualcosa di realmente accaduto. La regia mostra una minuziosa ricostruzione degli agenti in assetto antisommossa, con caschi, scudi e manganelli, ripresi prima dall’alto, poi all’interno nei minimi dettagli, in una serie di lunghe sequenze che sembrano interminabili per le crudeltà mostrate. Una violenza cieca, inaudita, a colpi di tonfa e calci su ragazzi e ragazze a mano in alto, colpiti selvaggiamente e ripetutamente in ogni parte del corpo – com’era accaduto prima a un giornalista – compresa la testa, causando spargimenti di sangue ovunque. L’edificio viene asserragliato da cima a fondo, e i pestaggi e le umiliazioni continuano – ricordiamo Alessandro Roja (il Dandi della serie Romanzo criminale) che spruzza un estintore addosso a un ragazzo – come nella peggiore delle dittature (fa ancora più impressione sapere che non siamo in un Paese lontano ma in Italia). La notizia circola, un ragazzo riprende con una telecamera dall’edificio di fronte, i giornalisti assistono esterrefatti ai feriti portati fuori dall’edificio. Ma non è finita. La regia di Vicari mostra in modo altrettanto esplicito le successive violenze nella caserma di Bolzaneto: il corridoio da incubo dove gli arrestati devono passare colpiti da entrambi i lati con manganellate selvagge, i ragazzi costretti a stare in piedi e in silenzio a suon di manganello, la Ulrich coperta di sputi, poi costretta a spogliarsi davanti ai poliziotti e umiliata nei bagni. Lo spettatore può tirare un (parziale) respiro di sollievo quando finalmente le scene di tortura finiscono: la testimonianza di Nick Janssen presso un giudice e i giornalisti che fotografano gli interni della scuola imbrattati di sangue danno inizio alla progressiva scoperta della verità, mentre un pullman accompagna malinconicamente gli arrestati stranieri (fra cui la Ulrich) al loro Paese. La didascalia finale racconta gli esiti del processo svoltosi lungo questi anni: un esito amaro, che vede solo alcuni dei responsabili pagare – e in modo lieve – per le loro colpe.
La colonna sonora
Realizzata da Teho Teardo, la colonna sonora di Diaz è abbastanza minimalista ma efficace: essendo un film di realistica denuncia e non di spettacolo, non ci sono temi musicali roboanti o che rimangono in mente, ma un insieme di sonorità che si insinuano sottopelle e accompagnano le immagini aumentando le sensazioni trasmesse (tensione, attesa, paura, amarezza). Il tutto è realizzato con strumenti di musica classica (violino, violoncello, chitarra, pianoforte, etc.), uniti e/o alternati a un uso accorto di sintetizzatori elettronici. Predominano i ritmi sincopati – pensiamo a quello che accompagna le ricorrenti immagini della bottiglia rotta – reiterati di frequenti durante il film, tonalità cupe che talvolta si mescolano coi rumori di quanto accade, oppure melodie tristi come nel finale quando i ragazzi stranieri escono dal carcere e partono in pullman verso i rispettivi Paesi.