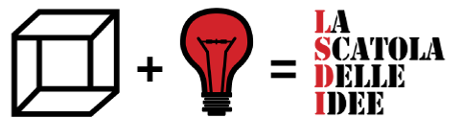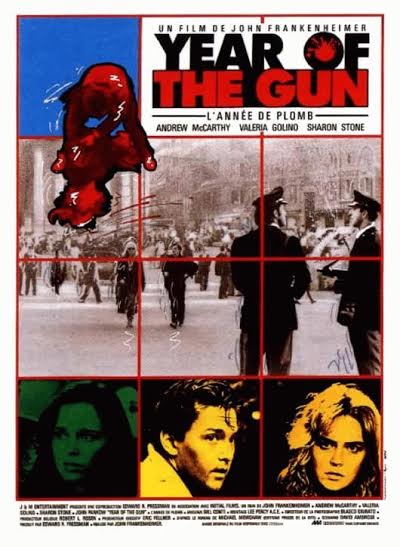Intorno al film
John Frankenheimer è stato uno dei registi più eclettici del panorama americano, per varie ragioni, e lo si può definire un autore “di confine”: è riuscito a fare da trait-d-union fra il cinema classico degli anni Sessanta e le “rivoluzioni” della Nuova Hollywood; è uscito dai confini statunitensi per girare film in diversi Paesi (Francia e Italia, per esempio); ha adottato uno stile e una narrazione versatile, passando attraverso vari generi con un’impronta squisitamente personale. Dal dramma (L’uomo di Alcatraz) al war-movie (Il treno), dal giallo alle spy-story fino al noir/poliziesco, Frankenheimer ha mescolato spesso i generi contrassegnando i suoi film con una massiccia dose di azione e suspense: ricordiamo gli spy-thriller Va’ e uccidi, Sette giorni a maggio e Black Sunday, il thriller fantascientifico Operazione diabolica, fino agli action puri come Il braccio violento della legge 2 e Ronin. Una fra le sue opere più riuscite e particolari, ingiustamente sottovalutata dalla critica, unisce un po’ tutta la filosofia cinematografica del regista e costituisce un unicum singolarissimo anche per l’ambientazione italiana: parliamo de L’anno del terrore (1991), opera che scava negli anni di piombo italiani trattando temi delicati come le Brigate Rosse, il sequestro Moro e l’ingerenza della CIA. È uno dei pochi casi in cui il cinema d’oltreoceano si sposta da noi per focalizzarsi su una realtà così scomoda: trattasi di una grossa produzione in cui Frankenheimer non vuole tanto fare denuncia quanto costruire un thriller (fanta)politico mozzafiato, e ci riesce a meraviglia con un film mozzafiato e quasi perfetto.
La vicenda
Nel 1978, il giornalista americano David Raybourne (Andrew McCarthy) torna a Roma dopo un periodo di assenza: sono ormai cinque anni che vive nella capitale italiana, scrivendo per l’American News, un piccolo quotidiano italiano in lingua inglese. Mentre coltiva una storia d’amore con la ricca Lia (Valeria Golino), sogna di scrivere un best-seller ambientandolo nel terrorismo italiano. La sua attenzione si focalizza in particolare sulle Brigate Rosse, e cerca aiuto nel professor Italo Bianchi (John Pankow), cugino di Valeria e uomo di sinistra ma apparentemente estraneo alla lotta politica. La grande occasione capita a David quando incontra la celebre fotoreporter Alison King (Sharon Stone), sempre in prima linea nelle zone di guerra: la ragazza, che ha scoperto il suo passato di presunto terrorista negli Stati Uniti, è convinta che il giornalista sia in contatto con membri delle BR e gli propone di collaborare con lei per scrivere un libro di successo. Su suggerimento del caporedattore, Raybourne ipotizza per il suo romanzo segreto il rapimento di Aldo Moro, senza sapere che il piano sta per essere effettuato realmente. A causa della sua confidenza con Italo, in realtà legato alle BR, finisce però in un giro molto pericoloso: i vertici dell’organizzazione sospettano che il giornalista sia al corrente del loro piano, e iniziano una caccia all’uomo verso Raybourne ed Alison.
Narrazione e stile
Tantissimi sono gli elementi di interesse de L’anno del terrore, tratto dal romanzo di Michael Mewshaw Year of the gun (1984), che dà il nome al titolo originale del film. Innanzitutto va notata la sua duplice essenza, derivante dalla regia statunitense di John Frankenheimer e dalla storia di ambientazione italiana, per cui confluiscono vari macro-filoni del cinema, ben amalgamati dalla solidissima regia. Da un lato, Year of the gun rientra in quel genere di spy-story definite “all’americana” proprio perché nate negli Stati Uniti con i registi della New Hollywood, a partire dagli anni Settanta, e incentrate sul lato più sporco dei servizi segreti: scompare lo spionaggio eroico e leggermente umoristico “alla James Bond” (che prosegue comunque per la sua strada), per metterne in scena gli aspetti più inquietanti, meschini e crudeli, le deviazioni, i legami col terrorismo, i torbidi intrecci politici, le torture praticate dagli agenti segreti, con film declinati di volta in volta in vari modi (thriller, action, film-inchiesta). Parliamo di pellicole monumentali come I tre giorni del Condor di Sidney Pollack, Tutti gli uomini del presidente di Alan J. Pakula, La conversazione di Francis Ford Coppola, Osterman Weekend e Killer Elite di Sam Peckinpah, Il maratoneta di John Schlesinger, solo per citare le più celebri e rilevanti. Questo genere di spy-story arriva anche in Europa, per esempio con i film di denuncia di Costa-Gavras (L’amerikano) e con il capolavoro francese Joss il professionista di Georges Lautner, mentre in Italia il genere “all’americana” attecchisce con il contagocce: pur essendo stati tra i primi a recepirlo con il seminale Assassination (1967) di Emilio P. Miraglia, negli anni successivi poche sono le pellicole di questo tipo, anche se tutte memorabili; l’esempio massimo è il capolavoro inarrivabile Goodbye & Amen di Damiano Damiani, ma ricordiamo anche il film-inchiesta Faccia di spia di Giuseppe Ferrara e gli ottimi Sono stato un agente CIA di Romolo Guerrieri, Russicum di Pasquale Squitieri e Piazza delle Cinque Lune di Renzo Martinelli. L’anno del terrore, che arriva un po’ fuori tempo massimo ma non ne risente affatto, fa da ideale conclusione a questo “ciclo” di film imperdibili (solo il film di Martinelli è successivo – del 2003 – e in un certo senso vi si collega), e al contempo è un trait-d-union fra il medesimo e un genere di film più squisitamente “all’italiana”. Come accadrà anni dopo con Ronin, in cui Frankenheimer unisce il suo stile d’azione americano con gli stilemi del polar francese, anche qui il regista dimostra la sua capacità camaleontica di adeguare estetica e narrazione al Paese in cui gira e al tipo di film che sta realizzando. La spy-story da New Hollywood si mescola brillantemente con il poliziesco all’italiana e il nostro cinema di denuncia – anche se ne L’anno del terrore l’elemento “impegnato” è secondario rispetto all’azione e alla suspense, trattandosi innanzitutto di uno spettacolare thriller politico che non ha troppe pretese di veridicità storica.
Frankenheimer mostra da subito la sua mano robusta e spettacolare introducendoci nell’atmosfera plumbea dell’epoca: i titoli con l’inquietante canto gregoriano che recita versi della Divina Commedia, l’arrivo di McCarthy in città e un brutale e realistico scontro di piazza fra manifestanti e polizia a colpi di manganelli e lacrimogeni. Al servizio di una sceneggiatura particolarmente complessa in cui vige la “regola del sospetto” (tutti, spettatori compresi, sospettano di tutti), entrano in scena man mano i vari personaggi che compongono l’intricato mosaico. Dopo il bello e spigliato McCarthy (Giorni felici a Clichy, Weekend con il morto e relativi sequel), prototipo del giornalista arrivista e coraggioso, entra in scena un altro attore hollywoodiano, John Pankow (Vivere e morire a Los Angeles, Talk Radio), nei panni invece del tipico professore/intellettuale di sinistra dell’epoca, e l’affascinante Valeria Golino – compagna del protagonista e solo in apparenza elemento di contorno. Il comparto femminile è particolarmente ricco, visto che la co-protagonista di spicco è la star Sharon Stone – non ancora famosissima visto che Basic instinct, il film che l’ha consacrata, arriva nel 1992, ma già carica di quell’erotismo spregiudicato che l’accompagnerà in tutta la sua carriera. Se Lia (la Golino) è una donna borghese separata da un marito violento e che proprio con Raybourne e il figlio cerca di iniziare una nuova vita, Alison King (la Stone) è una fotoreporter d’assalto che non a caso entra in scena durante una rapina. È la seconda scena d’azione del film, preludio a un crescendo sempre più fragoroso, girato al ralenti come nelle migliori opere di Peckinpah ma anche di Castellari e Squitieri, per restare in Italia: la sparatoria ricorda infatti i bei vecchi film polizieschi italiani, fra banditi con passamontagna e poliziotti, mitra e pistole che “cantano”, il tutto arricchito dall’originale inquadratura in soggettiva della macchina fotografica della Stone che immortala le immagini della rapina alternandosi alla sparatoria. Messi in scena tutti i personaggi, Year of the gun prosegue con un’escalation di suspense e azione, perfettamente bilanciate in una storia giallo/thriller mozzafiato. Il prototipo narrativo è quello dello sprovveduto che finisce coinvolto in una storia più grande di lui: così capita infatti a Raybourne, che cercando di scrivere un romanzo ambientato nel terrorismo italiano ha la sfortuna di entrare in contatto davvero con le Brigate Rosse. È un po’, se vogliamo, il principio del Pendolo di Foucault di Umberto Eco: tre appassionati di esoterismo inventano per gioco l’esistenza di un complotto dei Templari, salvo poi scoprire che è tutto reale e finire prigionieri di una pericolosa setta; nel nostro film, lo scrittore si basa sui fatti di cronaca che legge, immagina ruoli per le persone che conosce e addirittura ipotizza il sequestro di Aldo Moro da parte delle BR – un fatto che sta per accadere davvero. Ovviamente l’idea è un po’ una forzatura narrativa, e si potrebbe discutere sull’etica di un’operazione di questo tipo, ma limitandosi all’aspetto cinematografico il tutto funziona incredibilmente bene – del resto, non è la prima volta che nel cinema la Storia viene presa come pretesto per le “storie” immaginarie. Così, mentre Raybourne immagina che il caporedattore Pierre Bernier (George Murcell) sia un agente CIA in contatto con le BR, ed Alison King ritiene che sia invece il ragazzo ad avere contatti coi terroristi, vengono tutti messi in pericolo dall’unico a cui nessuno pensava – il “pacifico” professor Bianchi che, conoscendo il manoscritto segreto, scatena una spietata caccia all’uomo in cui entrano in scena altri due terroristi interpretati con la consueta efficacia da Mattia Sbragia e Lou Castel. La narrazione procede a livelli sempre sostenuti, con un ritmo incalzante e un’atmosfera complottista opprimente: peccato solo alcune lungaggini che forse si potevano evitare, in particolare le scene riguardanti le storie d’amore di McCarthy con la Golino prima e la Stone dopo, che hanno probabilmente la funzione di mettere in scena le grazie delle due splendide attrici ma che spezzano un po’ il ritmo.
Poco male, perché la tensione narrativa rimane a livelli sempre alti, grazie anche alle spettacolari scene d’azione (specialità del regista) che giungono talvolta improvvise e talvolta costruite con un climax crescente. Dopo gli scontri iniziali e la rapina in banca, vediamo la violenta irruzione dei banditi con mitra e passamontagna nella festa alla villa di Bernier, poi un’altra e più lunga sequenza di incidenti di piazza – quelli tanto diffusi all’epoca e rappresentati in tutto il loro brutale realismo – quando McCarthy e la Stone rimangono coinvolti fisicamente in uno scontro tra comunisti e neo-fascisti armati di bastoni. Notevole l’esecuzione a sangue freddo di George Murcell, freddato a colpi di pistola da due terroristi in moto, enfatizzato da un’inquadratura al ralenti, mentre da antologia è la caccia all’uomo fra i killer delle BR e i due giornalisti in fuga, che si conclude con una fragorosa sparatoria in una stalla. Infine, come già aveva fatto Giuseppe Ferrara nel film d’inchiesta Il caso Moro, anche Frankenheimer mette in scena la drammatica e sanguinaria strage della scorta di Aldo Moro e il rapimento del medesimo. Valorizzata dalla fotografia dell’italiano Blasco Giurato, la Roma dipinta dal regista è cupa e opprimente anche nelle scene diurne: grazie a una fedele ricostruzione storica di scenografie (Aurelio Crugnola) e oggetti, ci troviamo proiettati nella Roma violenta e plumbea degli anni Settanta, fra il Lungo Tevere, il Colosseo, strade e piazze del centro, i giardini di Villa Borghese, fino alla periferia. In questo senso – complice la presenza di vari caratteristi del poliziesco italiano anni Settanta in ruoli minori – si torna a respirare l’atmosfera anche di quel tipo di cinema, che nel 1991 era ormai scomparso. Notevole anche la sequenza ambientata a Venezia, con la riunione segreta dei terroristi un po’ esageratamente da spy-story vecchio stile – una tavola rotonda di misteriosi personaggi quasi da Spectre bondiana, in cui scopriamo a sorpresa che la Golino fa parte delle Brigate Rosse. L’anno del terrore procede quindi continuamente fra tutti questi binari: la spy-story all’americana, il giallo, il thriller politico, il poliziesco d’azione, il dramma storico e umano. Se la regia di Frankenheimer fa procedere tutto alla perfezione e con un ritmo incalzante, è dal punto di vista della veridicità storica che si perde un po’ (pensiamo per esempio al confronto finale nel covo dei terroristi), ma del resto non è questo l’obiettivo del regista: da notare il paragone meta-cinematografico che lo stesso Raybourne spiega nel corso del film, in cui paragona il suo libro al Giorno dello sciacallo (best-seller da cui Fred Zinnemann ha ricavato l’omonimo capolavoro dello spy-movie), cioè un’opera in cui convivono personaggi reali con altri fittizi. Più efficace, per quanto riguarda la denuncia sociale, la critica al cinico arrivismo di giornalisti e scrittori (categoria ben rappresentata da Raybourne ed Alison King) e al potere dei mass-media, che emerge in tutta la sua spietatezza nel discorso finale in televisione. Curiosa, nel corso del film, è la continua mescolanza fra stile americano e italiano: è particolarissimo vedere come convivono volti noti del cinema d’oltreoceano (i quattro protagonisti principali) con attori italiani (Sbragia) o comunque “adottati” dal nostro cinema (Castel), ma più in generale l’estetica e la forma narrativa, dovuta anche alla mescolanza nel cast tecnico (fotografia, montaggio, etc.) di maestranze americane e italiane: uno status “di confine” tipico di Frankenheimer e che rendono Year of the gun un film in un certo senso unico.
La colonna sonora
Il medesimo carattere “di confine” è rispecchiato dalle variegate musiche di Bill Conti. Come accennato in precedenza, Year of the gun inizia con un’inquietante brano in stile canto gregoriano che recita versi della Divina Commedia – un po’ il tipo di melodia sacrale che Squitieri aveva utilizzato nel 1988 per il suo Russicum – I giorni del diavolo. È forse il pezzo migliore della colonna sonora, che con il suo carattere cupo accresce l’atmosfera plumbea e opprimente. Si alternano efficaci pezzi ritmati da action-movie, per accompagnare i momenti più spettacolari e costruire la suspense, con altri dal sound americano quasi jazz (per esempio in una scena d’amore con la Golino), meno azzeccate e più stridenti con il contesto del film.